Il Progetto di Accoglienza è molto più che un rito di settembre: è il primo ponte tra scuola, studenti e famiglie. Con l’aiuto della psicopedagogista Lucia Todaro esploriamo perché l’accoglienza non sia un compito accessorio, ma uno stile relazionale che dà valore a chi entra e a chi accoglie.
Dalle esperienze dei diversi ordini scolastici alle idee pratiche raccolte nei PTOF, ecco come trasformare l’inizio dell’anno in un momento che lascia il segno.
 Perché il progetto di accoglienza è fondamentale
Perché il progetto di accoglienza è fondamentale
A settembre, come ormai tutti si aspettano, le prime attività scolastiche fanno parte di un progetto di accoglienza. E no, non è solo per abituarsi a riprendere il ritmo dopo una lunga estate piovosa.
Il Progetto Accoglienza, che ogni istituto mette in campo per i suoi studenti, è come la porta d’ingresso di un nuovo anno scolastico. E ogni scuola ha il proprio. Per questo figura nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che si trova pubblicato sui siti istituzionali.
Il PTOF è in fondo la “carta d’identità” di ogni scuola italiana: in sintesi è il documento dove si trova tutto quello che quella scuola e quei docenti vogliono fare, quando e come lo faranno e dove trovare cosa. E il Progetto Accoglienza fa parte di questa mappa del tesoro ed è diverso per ogni scuola perché ogni scuola è diversa, anche se resta sempre una scuola. Come ogni docente è diverso, pur restando sempre un docente.
Per approfondire il valore dell’accoglienza a scuola, ne abbiamo parlato con Lucia Todaro, psicopedagogista con oltre trent’anni di esperienza, che da sempre accompagna studenti, docenti e famiglie nei momenti più delicati del percorso educativo.
«L’accoglienza è qualcosa di speciale e nella scuola l'accoglienza dovrebbe essere uno stile, non soltanto un'organizzazione di progetti o di eventi, ma proprio uno stile relazionale, quello di chi da adulto va ad accogliere, quindi a raccogliere insieme bambini, ragazzi, studenti che da quel momento saranno un gruppo.»
Ogni anno a settembre le scuole mettono in campo i progetti di accoglienza, una serie di attività che trasversalmente accompagnano l’inserimento o la ripresa nell’ambito scolastico. Ma servono davvero agli studenti di ogni ordine e grado? E a che cosa?
«Nella mia esperienza di psicopedagogista ho visto che l’accoglienza viene organizzata e realizzata in modi diversi nei vari ordini di scuola: dal nido alla scuola dell’infanzia, dalla primaria alla secondaria di primo e secondo grado. Ormai la mentalità dell’accoglienza è entrata nelle aspettative delle famiglie e degli stessi ragazzi. A volte, però, capita che i docenti rischino di viverla come un semplice dovere in più. Mi è capitato di sentire dire che certi tentativi e pratiche di accoglienza sono inutili, perché i ragazzi, entrando alle superiori, sanno già come funziona e il tempo dedicato all’accoglienza sarebbe solo tempo perso, sottratto a ciò che per loro è davvero fondamentale: dare regole e farle rispettare. In realtà, l’accoglienza non è un compito accessorio. È simile a quella di un padrone di casa che apre la porta con un sorriso, invitando chi inizialmente è uno sconosciuto a entrare nel proprio spazio personale e facendolo sentire, poco alla volta, come a casa. Il senso dell'accoglienza dà valore sia all'esperienza di chi accoglie sia di chi è accolto. Non può esserci una vera collaborazione e un vero modo di stare insieme secondo gli obiettivi che la scuola ha, se prima non ci si sente accolti e si sa di accogliere. È un gesto, quello di entrare e quello di aprire la porta, che serve ad entrambe le parti. Per questo si dà tanta rilevanza ai progetti di accoglienza.»
Quindi questi progetti sono un esempio concreto dei valori dell’istituto e del suo modo di operare. Quali dovrebbero essere le caratteristiche di una accoglienza positiva?
«Accogliere a scuola non significa solo dare regole. Certo, le regole servono, ma la vera accoglienza è molto di più: è aiutare chi arriva a sentirsi a proprio agio, a trovare un posto e a imparare ad autoregolarsi. Un po’ come quando inviti qualcuno a casa tua: gli prendi la giacca, lo fai accomodare, gli fai capire come funziona la tua casa, ma in modo naturale, che lo faccia sentire benvenuto e non sotto esame. Quando un docente riesce a viverla davvero così, si accorge che l’accoglienza ha un ritorno enorme: chi arriva si sente accolto e chi accoglie si sente motivato e orgoglioso del proprio lavoro.Poi c’è un aspetto importante: spesso, a settembre, non sappiamo ancora nulla di loro. L’accoglienza serve proprio a questo: a creare il clima perché ogni studente senta che quel luogo è anche il suo. Naturalmente cambia molto a seconda del grado scolastico.»
Penso ai nidi che, proprio a fine luglio, quando si chiude un anno e se ne prepara un altro, si dedicano già all’accoglienza dei nuovi bambini. Spogliano gli ambienti da tutto ciò che può essere confusivo o eccessivo, creano angoli piacevoli e rassicuranti e preparano con cura i calendari dei colloqui con i genitori. È un lavoro fatto anche per le famiglie, che spesso vivono ansie legate al primo distacco: sentirsi accolti e accompagnati è fondamentale per loro quanto per i piccoli.»
«Penso poi alla scuola dell’infanzia. Anche qui tutto viene ripulito e reso luminoso, colorato e pronto per i nuovi arrivi. Molti bambini hanno già varcato quella soglia durante gli open day o in qualche momento di conoscenza, e ritrovare gli stessi spazi e gli stessi docenti li fa sentire meno estranei. Sono i piccoli gesti dei docenti, uno sguardo, un saluto, un invito a entrare, che trasformano la novità in familiarità.»
«Penso alla scuola primaria, dove l’accoglienza si intreccia con la continuità educativa. I bambini che arrivano dalla scuola dell’infanzia hanno spesso visitato la nuova scuola, partecipato a piccole attività come disegni, letture o lavoretti da portare in dono ai nuovi docenti. Questi materiali diventano promemoria emotivi: cambiano le mura, ma non cambia lo stile di benevolenza e attenzione che li accompagna.»
«Penso alla scuola secondaria di primo grado, dove il passaggio è più delicato. Qui i docenti si confrontano con quelli della primaria per conoscere meglio i nuovi alunni: non solo voti o schede, ma caratteristiche, bisogni e piccole fragilità che non sempre emergono dai documenti ufficiali. L’accoglienza si traduce in laboratori, incontri, visite guidate e attività con i ragazzi più grandi, che presentano la scuola e ne mostrano il funzionamento quotidiano, aiutando i nuovi arrivati a orientarsi.»
«Infine, penso alle scuole superiori. Qui l’accoglienza assume forme ancora diverse, spesso attraverso i progetti di peer education. Sono gli studenti più grandi ad accompagnare le matricole, a guidarle nei laboratori musicali, sportivi o creativi, a far conoscere gli spazi e a raccontare la vita della scuola. Per i nuovi arrivati è rassicurante scoprire che qualcuno “ce l’ha fatta” prima di loro, mentre per i tutor questa responsabilità è un’occasione per sentirsi utili e riconosciuti.»
«Alla fine, la verità è semplice: un’accoglienza positiva è quella in cui chi entra sente che qualcuno lo stava aspettando. E chi accoglie sa di aver costruito, fin dal primo giorno, un ponte che rende la scuola un luogo in cui vale la pena stare.»
Come si potrebbe rendere originale e significativo per tutto l’anno il momento dell’accoglienza?
«Sentirsi parte di un luogo fatto di relazioni autentiche e avere un legame significativo, non solo formale, con coetanei e adulti che diventano punti di riferimento: questo è il vero valore dei progetti di accoglienza. Queste esperienze non fanno crescere solo gli studenti, ma anche gli adulti che li accompagnano (educatori, docenti, dirigenti) perché permettono di riscoprire la dimensione più umana della scuola: empatia, attenzione alla persona, desiderio di relazione. In un sistema scolastico spesso appesantito da burocrazia e numeri, l’accoglienza ricorda che stare a scuola non è solo gestire una classe. Ci sono docenti, ad esempio di discipline scientifiche o tecnologiche, che traggono un grande beneficio dal mettersi in gioco in attività nuove, prima in fase iniziale e poi con continuità, se scelgono di assumersi responsabilità o se nasce in loro la passione di proseguire. Io credo che un docente che approfitti della possibilità di partecipare ad un progetto di accoglienza ne trarrà un valore incredibile in termini di crescita umana personale, in termini di riscontro di autorevolezza verso gli alunni, in termini di capacità e di competenza nella collaborazione con i colleghi, in termini di riconoscimento di valore agli occhi dei genitori, in termini di soddisfazione. Certo ci vuole, come dicevo prima, che uno ci metta le proprie competenze, tanta passione, tanto impegno, tutta la propria creatività, una buona capacità di collaborazione, anche un po' la fatica di aprire quella porta. Se uno pensa che sia utile, funzionale all'entrare in relazione, non potrà che essere un arricchimento. Vedo tanto entusiasmo da parte di tanti docenti nell'organizzare progetti di accoglienza e non solo perché sono un obbligo. Mi piacerebbe che oltre a quell'entusiasmo ci fosse la reale consapevolezza di quanto lascia un segno importante negli alunni, piccoli o grandi che siano, quello che loro stanno facendo in quelle settimane.»
Il momento dell’accoglienza ha un profondo valore relazionale. Ad esempio, l’IC Carducci di San Vittore Olona ricorda nella presentazione del proprio progetto Accoglienza che “Accogliere un bambino nella scuola dell’infanzia significa molto più che farlo entrare nell’edificio della scuola, assegnargli una sezione e trovargli un posto dove stare. L’accoglienza è un metodo di lavoro complesso, è un modo di essere dell’adulto, è un’idea chiave del processo educativo”.
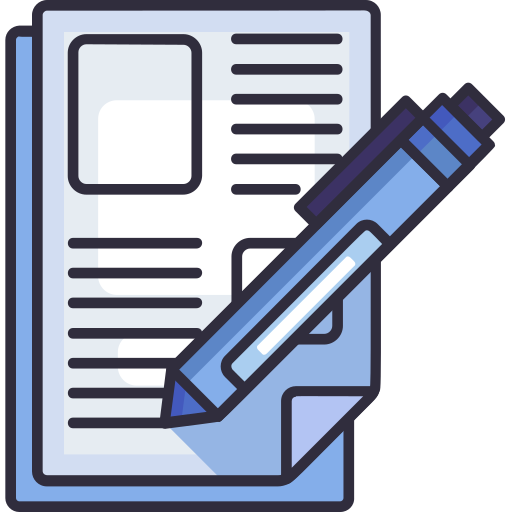 Idee concrete per un’accoglienza efficace
Idee concrete per un’accoglienza efficace
Ogni scuola interpreta l’accoglienza a modo suo, ma alcune pratiche tornano spesso nei PTOF e hanno dimostrato di funzionare. Abbiamo raccolto qui alcune idee e spunti che possono ispirare progetti efficaci e significativi per docenti, studenti e famiglie.
- Cerimonie di benvenuto e rituali iniziali
Un saluto del dirigente, un piccolo dono simbolico o uno spettacolo organizzato dagli studenti più grandi: sono gesti semplici ma potenti, che creano fin da subito un senso di appartenenza. Il clima della scuola si colora di positività e studenti e famiglie si sentono accolti emotivamente, come in una vera comunità.
- Attività di socializzazione in classe
Giochi di gruppo, laboratori creativi, momenti di circle time o semplici presentazioni aiutano a superare la timidezza dei primi giorni. Queste attività favoriscono la nascita di amicizie, stimolano la collaborazione e permettono al gruppo classe di costruire coesione e serenità.
- Tutoraggio tra pari e continuità tra ordini di scuola
Il peer tutoring (con studenti più grandi che accompagnano i nuovi) e le attività di raccordo tra infanzia, primaria e secondaria facilitano un inserimento più graduale. Ne beneficiano tutti: i nuovi studenti si sentono sostenuti, mentre i tutor sviluppano empatia, responsabilità e capacità di leadership.
- Coinvolgimento delle famiglie
Open day, incontri informativi o inserimenti graduali permettono ai genitori di affrontare con serenità il distacco e di sentirsi parte di una vera alleanza educativa. Questo sostegno si riflette anche sui più piccoli, che percepiscono sicurezza emotiva e fiducia nel nuovo ambiente scolastico.
- Progetti di accoglienza continuativi
L’accoglienza non si esaurisce a settembre: può proseguire durante l’anno con laboratori, peer education e attività condivise. Un esempio è l’“albero dei progetti”, dove si fissano insieme obiettivi e possibili ostacoli. Questa pratica rafforza la motivazione, migliora il clima di classe, sostiene i docenti nel prevenire il burnout e rende più consapevoli studenti e docenti del cammino da intraprendere.
- Gite di inizio anno
Uscite all’aperto come parchi avventura, percorsi in montagna o esperienze sportive di gruppo diventano occasioni preziose per costruire fiducia reciproca. La condivisione di queste esperienze rafforza lo spirito di squadra, aumenta la motivazione e favorisce il benessere psicofisico degli studenti.
 Lucia Todaro
Lucia Todaro
Lucia Todaro è una psicopedagogista con oltre trent'anni di esperienza: il suo focus è il benessere emotivo delle persone che incontra. A questo ha dedicato il suo libro “La felicità possibile - Piccoli indizi di quotidiana saggezza”, Feltrinelli (2024). Laureata in Filosofia con indirizzo in Scienze umane, ha iniziato la sua carriera nella selezione e formazione aziendale, ma la sua passione l’ha guidata verso la consulenza psicopedagogica e la formazione, collaborando costantemente con scuole (docenti, studenti e genitori), università della terza età e associazioni. Dal 1995, è anche formatrice per il Centro Sportivo Italiano, contribuendo a progetti educativi e motivazionali.
Agosto 2025 - Questo articolo è a cura di 

